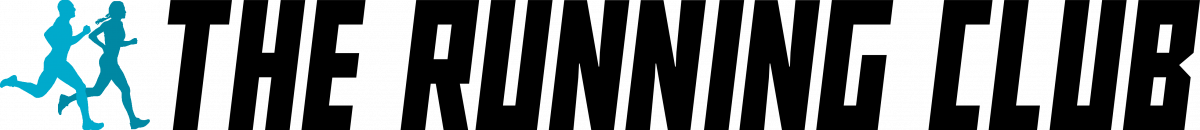Il ferro è un micronutriente fondamentale per il corretto funzionamento dell’organismo umano, e la sua importanza cresce esponenzialmente quando si parla di sport di resistenza, come la corsa. Per i runner, il ferro non è solo una questione di salute generale, ma un vero e proprio fattore determinante per la performance atletica. La sua presenza, o la sua carenza, può influenzare direttamente la capacità di trasporto dell’ossigeno, la resistenza alla fatica e il recupero muscolare.
Il ferro è uno dei metalli più abbondanti sulla Terra, ma la sua forma naturale – prevalentemente come ossido ferrico (Fe³⁺) – è chimicamente stabile e poco biodisponibile. Nell’organismo umano, il ferro può esistere in due stati di ossidazione: il ferro bivalente (Fe²⁺), noto come ferro eme, e il ferro trivalente (Fe³⁺), più comune in natura ma meno facilmente assimilabile.
Il ferro eme è la forma biologicamente attiva, presente nelle proteine come emoglobina e mioglobina, che legano e trasportano l’ossigeno nel sangue e nei muscoli. Il ferro trivalente, invece, necessita di essere convertito in ferro bivalente per poter essere assorbito efficacemente, processo che avviene in ambiente acido, come quello gastrico.
Funzioni fisiologiche del ferro
Il ferro è coinvolto in numerosi processi fisiologici. La sua funzione più nota è quella di costituente dell’emoglobina, la proteina che trasporta l’ossigeno dai polmoni ai tessuti. Nei muscoli, il ferro è parte integrante della mioglobina, che immagazzina e rilascia ossigeno durante la contrazione muscolare. Queste due proteine sono fondamentali per il metabolismo aerobico, cioè per la produzione di energia in presenza di ossigeno.
Ma il ferro non si limita al trasporto dell’ossigeno. È anche coinvolto nella catena respiratoria mitocondriale, dove partecipa al trasferimento di elettroni e alla sintesi di ATP, la molecola energetica per eccellenza. Inoltre, è presente in numerosi enzimi che regolano la sintesi del DNA, la risposta immunitaria e la detossificazione cellulare.
Nel contesto sportivo, è interessante notare come il ferro influenzi la composizione muscolare. Le fibre muscolari rosse, tipiche degli sport di resistenza, sono ricche di mioglobina e quindi di ferro. Al contrario, le fibre bianche, più adatte agli scatti e alla forza esplosiva, ne contengono meno. Questo spiega perché i runner, che utilizzano prevalentemente fibre rosse, abbiano un fabbisogno di ferro più elevato rispetto ad altri atleti.
Assorbimento del ferro
Nonostante la sua importanza, l’assorbimento del ferro è sorprendentemente inefficiente. Si stima che solo il 10% del ferro introdotto con la dieta venga effettivamente assimilato. Il ferro eme, presente in alimenti di origine animale come carne, pesce e pollame, è assorbito con maggiore efficacia rispetto al ferro non eme, contenuto in vegetali e legumi.
L’acidità gastrica è un fattore chiave per la conversione del ferro trivalente in ferro bivalente. Inoltre, la presenza di vitamina C (acido ascorbico), zuccheri e amminoacidi facilita la chelazione del ferro, rendendolo più biodisponibile. Da qui il consiglio pratico: aggiungere succo di limone o agrumi ai pasti vegetali, non alla carne, per migliorare l’assorbimento del ferro non eme.
Le principali fonti di ferro sono:
- Carne rossa, fegato, frattaglie (ferro eme)
- Pesce e pollame
- Verdure a foglia verde, legumi, cereali integrali (ferro non eme)
- Spirulina, un’alga ricca di ferro, spesso utilizzata dai vegetariani
L’integrazione può essere utile in caso di carenza, ma va gestita con attenzione. Oggi esistono formulazioni sublinguali che bypassano il tratto gastrointestinale, migliorando l’assorbimento e riducendo gli effetti collaterali come nausea o costipazione.
Parametri da monitorare nello sportivo
Per valutare lo stato del ferro nell’organismo, soprattutto negli sportivi, è fondamentale monitorare tre parametri ematici:
- Sideremia: indica la quantità di ferro circolante nel sangue.
- Ferritina: rappresenta il ferro di deposito, ovvero le riserve dell’organismo.
- Transferrina: è la proteina che trasporta il ferro nel sangue.
Nel runner, la ferritina assume un ruolo centrale. Mentre nella popolazione generale un valore di 20 ng/mL può essere considerato sufficiente, nello sportivo si raccomanda di mantenere la ferritina sopra i 50 ng/mL per evitare carenze funzionali che compromettono la sintesi di emoglobina e mioglobina.
Perdite di ferro nel runner
Gli sportivi, e in particolare i runner, sono soggetti a perdite di ferro superiori alla media. Oltre alle perdite fisiologiche attraverso le feci, le donne in età fertile perdono ferro con il ciclo mestruale, e le donne in gravidanza hanno un fabbisogno aumentato.
Nel runner, si verifica una perdita ematica da impatto: ogni passo genera microtraumi che causano la rottura di globuli rossi e la conseguente perdita di emoglobina e ferro. Inoltre, le diete ipocaloriche spesso adottate per mantenere il peso corporeo basso possono ridurre l’apporto di ferro. Alcuni studi hanno anche evidenziato un aumento delle perdite gastrointestinali nei maratoneti, probabilmente legato allo stress fisico prolungato.
Sintomi da carenza e sovraccarico di ferro
La carenza di ferro si manifesta con sintomi quali:
- Stanchezza cronica
- Debolezza muscolare
- Pallore
- Dispnea (difficoltà respiratoria)
- Palpitazioni
- Sensazione di freddo
- Parestesie (formicolii a mani e piedi)
A livello ematico, si osserva una anemia microcitica, caratterizzata da globuli rossi più piccoli del normale. La condizione può essere trattata con integrazione di ferro, ma il recupero può richiedere settimane o mesi, a seconda della gravità.
Al contrario, un eccesso di ferro può causare irritazione intestinale, nausea, costipazione, diarrea e, nei casi più gravi, danni a fegato, reni e sistema nervoso centrale. Tuttavia, è raro che l’alimentazione o l’integrazione orale provochino tossicità; i rischi aumentano solo con somministrazioni endovenose.
Donazioni di sangue e gestione del ferro
Donare sangue è un gesto nobile e utile, ma per gli sportivi è preferibile evitare di farlo nei giorni immediatamente precedenti o successivi a una gara, per non compromettere la performance o falsare i valori ematici. Dopo una maratona, ad esempio, è normale osservare un aumento delle transaminasi e della creatina chinasi, segno di stress muscolare e epatico. Meglio attendere qualche giorno per permettere all’organismo di recuperare.
Il ferro è molto più di un semplice minerale: è un indicatore di salute, di efficienza metabolica e di capacità prestazionale. Per il runner, monitorare i livelli di ferro non è solo una precauzione, ma una strategia per migliorare la qualità dell’allenamento e della gara. Un emocromo ogni 2-3 mesi, accompagnato da un controllo di ferritina, sideremia e transferrina, può fare la differenza tra una stagione brillante e una segnata dalla fatica.