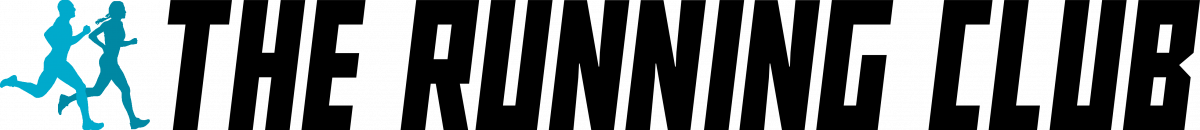Sir Mohamed Muktar Jama Farah, meglio conosciuto come Mo Farah, è considerato uno dei più grandi mezzofondisti della storia dell’atletica. Nato in Somalia nel 1983 con il nome Hussein Abdi Kahin, è stato vittima di traffico di minori e portato illegalmente nel Regno Unito all’età di nove anni. Solo grazie all’intervento di un insegnante di educazione fisica, che ne ha riconosciuto il talento e lo ha sostenuto, ha potuto iniziare a correre e costruire una carriera straordinaria. Da quel momento, la sua ascesa è stata inarrestabile.
Mo Farah ha vinto quattro medaglie d’oro olimpiche: due nei 5.000 metri e due nei 10.000 metri, conquistate tra Londra 2012 e Rio 2016. A queste si aggiungono sei titoli mondiali e numerosi successi europei. È l’unico atleta britannico ad aver completato il “double-double” olimpico e mondiale nelle gare di lunga distanza.
Dopo aver dominato la pista per oltre un decennio, ha affrontato la sfida della maratona, vincendo la Chicago Marathon nel 2018 con il record britannico di 2h05’11”.
Oggi, Mo Farah ha lasciato le competizioni professionistiche, ma non ha smesso di correre. Si dedica a progetti educativi e sociali, con l’obiettivo di restituire ciò che ha ricevuto e ispirare le nuove generazioni.
Lo abbiamo incontrato a Roma, presso lo stand Huawei della Rome Half Marathon, e abbiamo avuto l’occasione di parlare con lui in un’intervista, in cui ha ripercorso la sua carriera, raccontato il passaggio dalla pista alla maratona, condiviso il suo impegno con i giovani e riflettuto sul ruolo fondamentale che lo sport ha avuto nella sua vita.
Intervista a Mo Farah
Qual è il ricordo più emozionante della tua carriera?
“Ho vissuto una carriera straordinaria, che mi ha portato da ragazzino sconosciuto a diventare un atleta riconosciuto a livello mondiale. Ma se devo scegliere un momento, quello che ha segnato tutto è stato Londra 2012. Vincere le Olimpiadi in casa, davanti al mio pubblico, è stato qualcosa di indescrivibile. 75.000 persone che gridavano il mio nome, tutta la nazione che mi sosteneva. È stato un sogno che si è realizzato, e quell’emozione mi ha accompagnato per tutta la carriera. Quando sei giovane e qualcuno ti dice che potresti vincere le Olimpiadi, sembra impossibile. Ma farlo davvero, e farlo a casa, è stato il massimo”.
Hai avuto una carriera incredibile in pista, ma anche su strada hai ottenuto risultati importanti. Cosa ti ha spinto a fare questo passaggio?
“Dopo tanti anni in pista, sentivo il bisogno di una nuova sfida. Pensavo che, essendo stato un grande atleta nei 10.000 metri, sarei stato naturalmente portato per la maratona. Ma ho scoperto che non è così semplice. La pista e la strada sono due mondi diversi. In pista puoi controllare il ritmo, cambiare strategia, accelerare nel finale. Su strada, invece, devi mantenere una velocità costante per oltre due ore. È una prova completamente diversa, sia fisicamente che mentalmente”.
Ti è mancato qualcosa per dominare anche nella maratona come hai fatto in pista?
“Sì, credo di aver avuto buoni risultati, ma mi è mancato quel piccolo margine, quel 0,1% che fa la differenza tra essere competitivo e essere dominante. In pista ero come un animale selvaggio: rallentavo, acceleravo, cambiavo ritmo e poi nel giro finale davo tutto. Nella maratona non puoi fare questo. Devi essere regolare, preciso, e ogni errore si paga caro. Ho sempre cercato di essere onesto con me stesso, di analizzare le sensazioni, di capire cosa non funzionava e di correggerlo. Questo approccio mi ha aiutato molto, ma ho capito che la mia forza era sulla pista”.
Hai comunque ottenuto risultati di rilievo, come il terzo posto alla London Marathon e la vittoria a Chicago. Come li valuti oggi?
“Essere arrivato terzo a Londra è stato bellissimo, ma volevo vincere. A Chicago, nel 2018, ho corso in 2h05’ e ho stabilito il record britannico. È stato un grande traguardo. Ma se guardiamo ai migliori maratoneti, quelli che corrono in 2h04’ o meno, capiamo che serve qualcosa in più. Probabilmente ero più adatto alla pista. Basta guardare Eliud Kipchoge: in pista non ha brillato, ma in maratona è diventato leggenda. Ogni atleta ha il suo terreno ideale e io ho capito che il mio era la pista”.

Ora che ti sei ritirato, pensi di dedicarti alla formazione dei giovani atleti?
“Assolutamente sì. È fondamentale restituire ciò che ho ricevuto. Ho quattro figli e cerco di educarli all’attività fisica, ma voglio fare di più. Se non fosse stato per i miei insegnanti e per chi ha creduto in me, non sarei qui. Per questo ho creato la mia charity con la Youth Sports Trust che sostiene i giovani nello sport. Il progetto si chiama Mo’s Mission e punta a cambiare le politiche governative per garantire più accesso allo sport nelle scuole. Dopo il 2012, molti fondi sono stati tagliati, e i ragazzi fanno sempre meno attività fisica. Questo ha conseguenze enormi sulla salute e sul futuro”.
Continui a correre?
“Sì, ma non in modo competitivo. Ho sempre avuto un obiettivo nella vita, e ora il mio è correre una volta a settimana o ogni dieci giorni, per liberare la mente. Spesso corro con i miei figli, facciamo jogging, ciclismo, giochiamo a calcio. Non metto pressione su di loro, voglio che siano semplicemente attivi e felici. È anche uno dei motivi per cui sono qui a Roma: vedere quante persone corrono, condividere esperienze, e promuovere uno stile di vita sano”.
Che consiglio daresti a un ragazzo che vuole iniziare a correre, anche solo per stare meglio fisicamente?
“Direi semplicemente: esci e fallo. Non metterti pressione. Viviamo in tempi complicati, pieni di distrazioni, social media, eventi. È importante prendersi del tempo per sé, fare qualcosa che ci fa stare bene. Che sia corsa, nuoto, calcio, non importa. L’importante è muoversi, sentirsi vivi. E va bene sbagliare, l’importante è imparare. Lo sport è uno strumento potente per migliorare la propria vita”.