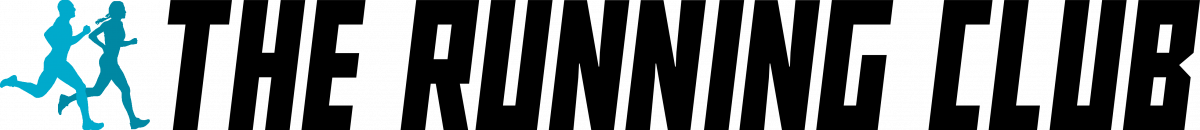Oltre ai macronutrienti fondamentali — proteine, carboidrati e grassi — il nostro organismo necessita di una costante e bilanciata assunzione di micronutrienti, in particolare vitamine e sali minerali. Questi composti, pur presenti in quantità minime, svolgono ruoli cruciali per il mantenimento della salute, il corretto funzionamento metabolico e la prevenzione di numerose patologie.
Il termine “vitamina” deriva da “amine della vita”, poiché inizialmente si pensava che tutte le vitamine fossero ammine indispensabili per la sopravvivenza. Oggi sappiamo che non tutte lo sono chimicamente, ma il concetto di essenzialità rimane valido: le vitamine sono nutrienti che il corpo umano non è in grado di sintetizzare in quantità sufficienti, fatta eccezione per alcune — come la vitamina D, la K e alcune del gruppo B — che possono essere prodotte in parte dall’organismo.
Classificazione: idrosolubili e liposolubili
Le vitamine si distinguono in due grandi categorie:
- Idrosolubili, come la vitamina C e il complesso B, che si sciolgono in acqua e agiscono prevalentemente nel citoplasma cellulare.
- Liposolubili, come le vitamine A, D, E e K, che si dissolvono nei grassi e si localizzano nelle membrane cellulari.
Questa distinzione non è solo chimica, ma funzionale: le vitamine idrosolubili vengono eliminate facilmente con le urine, mentre quelle liposolubili tendono ad accumularsi nei tessuti adiposi, rendendo più probabile un eventuale sovradosaggio.
Vitamina C ed E: il sistema antiossidante del runner
La vitamina C (idrosolubile) e la vitamina E (liposolubile) rappresentano una coppia sinergica nel contrasto allo stress ossidativo. Durante l’attività fisica intensa, come la corsa di lunga durata, si produce una quantità significativa di radicali liberi (ROS), molecole instabili che danneggiano le strutture cellulari.
La vitamina E, presente nelle membrane cellulari, si “sacrifica” neutralizzando i ROS, ma una volta ossidata perde la sua funzione. È qui che interviene la vitamina C, che rigenera la vitamina E trasferendole elettroni e ripristinandone l’attività. Questo meccanismo di difesa è fondamentale per chi pratica sport di endurance, dove il bilancio ossidativo può diventare critico.
Oltre alla funzione antiossidante, la vitamina C stimola la sintesi del collagene, rafforzando tendini e articolazioni, e supporta il sistema immunitario.
Fonti alimentari
- Vitamina C: agrumi, kiwi, fragole, pomodori, verdure a foglia verde.
- Vitamina E: olio extravergine d’oliva, frutta secca, avocado.
Rischi da eccesso
L’eccesso di vitamina C, se protratto nel tempo, può favorire la formazione di ossalati e calcoli renali. La dose consigliata è di circa 250 mg al giorno, mentre dosi superiori dovrebbero essere assunte solo per brevi periodi e sotto controllo. L’eccesso di vitamina E è raro, data la sua minore diffusione negli alimenti e negli integratori.
Vitamine del gruppo B: energia, metabolismo e salute del sistema nervoso
Le vitamine del gruppo B costituiscono una famiglia numerosa e funzionalmente molto articolata, composta da otto principali composti: B1 (tiamina), B2 (riboflavina), B3 (niacina), B5 (acido pantotenico), B6 (piridossina), B7 (biotina), B9 (folati) e B12 (cobalamina). Queste vitamine sono tutte idrosolubili, il che significa che si sciolgono in acqua e non vengono immagazzinate in modo significativo nell’organismo, rendendo necessaria una loro assunzione regolare attraverso l’alimentazione.
La caratteristica comune a tutte le vitamine del gruppo B è il loro ruolo come cofattori enzimatici. In altre parole, esse non partecipano direttamente alle reazioni chimiche, ma sono indispensabili per attivare gli enzimi che le catalizzano. Senza questi cofattori, molte reazioni metaboliche fondamentali non potrebbero avvenire, con conseguenze potenzialmente gravi per la salute e la performance fisica.
È importante sottolineare che non tutte le vitamine generano coenzimi, ma tutti i coenzimi derivano da vitamine, e in particolare da quelle del gruppo B. Questo rende il complesso B cruciale per il metabolismo energetico, la sintesi di neurotrasmettitori, la produzione di globuli rossi e il mantenimento della salute neurologica.
Funzioni specifiche delle singole vitamine B
- B1 (Tiamina): è il cofattore del tiamina pirofosfato (TPP), essenziale per il metabolismo dei carboidrati e per il corretto funzionamento del ciclo di Krebs, il processo biochimico che produce energia a livello cellulare.
- B2 (Riboflavina): precursore di FAD (flavina adenina dinucleotide) e FMN (flavina mononucleotide), è coinvolta nelle reazioni di ossidoriduzione e nel metabolismo di grassi e amminoacidi.
- B3 (Niacina): dà origine a NAD⁺ e NADP⁺, coenzimi fondamentali per il metabolismo energetico, la biosintesi degli acidi grassi e la riparazione del DNA.
- B5 (Acido pantotenico): è parte integrante del Coenzima A (CoA), che interviene nel metabolismo degli acidi grassi e nel ciclo di Krebs.
- B6 (Piridossina): si trasforma in piridossal fosfato (PLP), cofattore chiave per le reazioni di transaminazione e per la sintesi di neurotrasmettitori come serotonina e dopamina.
- B7 (Biotina): agisce come cofattore delle carbossilasi, enzimi coinvolti nella gluconeogenesi, nella sintesi degli acidi grassi e nel metabolismo degli amminoacidi.
- B9 (Folati): è implicata nel trasferimento di unità monocarboniose (formil, metil, metilenici), nella sintesi di purine e pirimidine, nella metilazione del DNA e nella sintesi degli amminoacidi.
- B12 (Cobalamina): partecipa a due reazioni fondamentali, tra cui la metilazione dell’omocisteina a metionina. È essenziale per la sintesi del DNA, per la salute del sistema nervoso e per la formazione dei globuli rossi.
Ruolo nel metabolismo e nello sport
In sintesi, le vitamine del gruppo B svolgono tre funzioni principali:
- Trasformazione dei macronutrienti (carboidrati, grassi e proteine) in energia utilizzabile.
- Supporto alla funzione neurologica, contribuendo alla sintesi e al funzionamento dei neurotrasmettitori.
- Stimolo alla produzione di globuli rossi, migliorando il trasporto dell’ossigeno ai tessuti e ai muscoli.
Per chi pratica sport, e in particolare per i runner, è fondamentale garantire un apporto adeguato di tutte le vitamine del complesso B, attraverso una dieta equilibrata e, se necessario, mediante integrazione mirata.
Focus sulla vitamina B12
La vitamina B12 merita un’attenzione particolare per due motivi principali:
- Metilazione dell’omocisteina: l’omocisteina è un metabolita associato all’infiammazione cardiovascolare. Livelli elevati sono considerati un fattore di rischio. La B12, insieme ai folati (B9), contribuisce a ridurne la concentrazione, prevenendo la cosiddetta “trappola dei folati”, che si verifica quando i livelli di B12 sono troppo bassi per attivare i folati.
- Produzione di globuli rossi: una carenza di B12 può compromettere la sintesi dell’emoglobina, riducendo la capacità del sangue di trasportare ossigeno ai muscoli e agli organi, con impatto diretto sulla resistenza e sulla performance sportiva.
Dopo i 50 anni, il rischio di carenza aumenta per due ragioni: la riduzione del consumo di alimenti di origine animale e la diminuzione dell’efficienza della flora batterica intestinale, che contribuisce alla sintesi della B12. Inoltre, con l’età si riduce la produzione del fattore intrinseco, una proteina gastrica indispensabile per l’assorbimento intestinale della vitamina B12. Senza questo fattore, anche l’integrazione può risultare inefficace.
Fonti alimentari
Le vitamine del gruppo B si trovano in una vasta gamma di alimenti:
- Carne, pesce, uova
- Legumi, frutta secca, cereali integrali
- Verdure a foglia verde
Le persone che seguono diete vegane o ipocaloriche per lunghi periodi dovrebbero valutare con attenzione la possibilità di integrare, soprattutto la B12.
Rischi da eccesso
Le vitamine del gruppo B, essendo idrosolubili, vengono eliminate facilmente attraverso le urine. Questo rende molto raro il rischio di sovradosaggio, anche in caso di integrazione. Tuttavia, è sempre consigliabile evitare l’assunzione indiscriminata e preferire un approccio personalizzato, basato su analisi e monitoraggio.
Vitamine Liposolubili A, K, D
Le vitamine A, K e D appartengono alla categoria delle vitamine liposolubili, ovvero quelle che si dissolvono nei grassi e si trovano in prossimità delle molecole lipidiche all’interno dell’organismo. Questo significa che, a differenza delle vitamine idrosolubili che si distribuiscono nei compartimenti acquosi delle cellule, le vitamine liposolubili tendono ad accumularsi nelle membrane cellulari, nei tessuti adiposi e in altre strutture ricche di lipidi. La loro presenza in questi ambienti è fondamentale per svolgere funzioni biologiche specifiche, come la regolazione del metabolismo del calcio (vitamina D), la coagulazione del sangue (vitamina K) e la protezione della pelle e della vista (vitamina A).
Vitamina A: antiossidante, immunitaria e visiva
La vitamina A è presente nell’organismo umano e negli alimenti in due principali forme: retinoidi, che rappresentano la forma attiva, e carotenoidi, che agiscono come pro-vitamina A. Tra questi ultimi, il beta-carotene è il più noto e facilmente riconoscibile per il suo caratteristico colore arancione. È interessante notare che un consumo eccessivo di alimenti ricchi di beta-carotene può provocare una colorazione aranciata del palmo delle mani, fenomeno benigno ma indicativo di un accumulo significativo.
Dal punto di vista funzionale, la vitamina A svolge numerosi ruoli biologici:
- Contribuisce alla salute della pelle, grazie alla sua azione antiossidante contro gli agenti esterni e lo stress ossidativo.
- È essenziale per il corretto funzionamento della vista, in particolare nella visione notturna e crepuscolare.
- Supporta il sistema immunitario, favorendo la risposta difensiva dell’organismo.
Le fonti alimentari di vitamina A includono fegato e uova, che contengono la forma attiva. I carotenoidi, invece, si trovano in abbondanza in alimenti di colore arancione come carote, zucca, melone e albicocche. Essendo una vitamina liposolubile, il suo assorbimento è facilitato dalla presenza di grassi nella dieta.
Vitamina D: molto più del calcio
La vitamina D è tra le vitamine più studiate negli ultimi anni, e la ricerca ha evidenziato che il suo ruolo va ben oltre la fissazione del calcio nelle ossa. È infatti coinvolta in numerosi processi fisiologici, tra cui la modulazione del sistema immunitario e la regolazione dell’infiammazione. I recettori della vitamina D sono stati individuati in diversi organi e tessuti, tra cui muscoli, cervello, cuore e persino apparato riproduttivo, confermando la sua azione sistemica.
La vitamina D può essere sintetizzata dall’organismo attraverso l’esposizione ai raggi ultravioletti del sole, ma questa produzione è spesso insufficiente. Le difficoltà derivano da:
- La scarsa esposizione solare, soprattutto nelle ore centrali della giornata.
- L’uso diffuso di creme solari con fattore di protezione superiore a 30, che impediscono la sintesi cutanea della vitamina.
- Una dieta moderna spesso povera di grassi, elemento necessario per l’assorbimento di questa vitamina liposolubile.
Le principali fonti alimentari sono i pesci grassi (come salmone, sgombro e aringa) e le uova. Come per la vitamina B12, anche la vitamina D deve essere monitorata regolarmente, soprattutto in soggetti sportivi o esposti a stress cronico. In caso di carenza, è possibile ricorrere all’integrazione, ma con attenzione ai dosaggi.
In particolare, quando si superano le 5.000–10.000 unità internazionali (UI) al giorno, è consigliabile associare la vitamina D alla vitamina K2, per evitare il rischio di calcificazioni vascolari. La vitamina D, infatti, favorisce il deposito di calcio, che in assenza di un corretto bilanciamento può accumularsi nei vasi sanguigni. Questi dosaggi elevati rientrano nella prescrizione medica, e non devono essere gestiti autonomamente.
Attenzione all’eccesso
Sebbene sia difficile raggiungere livelli tossici di vitamina D, un’assunzione eccessiva può comportare rischi cardiovascolari legati alla calcificazione dei tessuti molli. È quindi fondamentale evitare il fai-da-te e affidarsi a professionisti per la valutazione e l’eventuale integrazione.
Vitamina K: coagulazione e sinergia con la D
La vitamina K è un altro micronutriente liposolubile di grande importanza, soprattutto per il suo ruolo nella coagulazione del sangue e nella regolazione del metabolismo del calcio. Esistono due forme principali:
- Vitamina K1, presente nelle verdure a foglia verde come spinaci, cavolo e lattuga.
- Vitamina K2, contenuta in formaggi stagionati, soia fermentata e carne.
La vitamina K è coinvolta nella sintesi dei fattori della coagulazione, ed è per questo che viene monitorata attentamente nei pazienti in terapia anticoagulante con farmaci come il warfarin o il cumadin. In questi casi, l’alimentazione deve essere standardizzata per garantire l’efficacia del farmaco. Va detto che oggi esistono farmaci di nuova generazione che non richiedono questo tipo di controllo dietetico.
Un altro aspetto interessante riguarda la produzione endogena della vitamina K, che avviene grazie alla flora batterica intestinale. Tuttavia, con l’avanzare dell’età, questa produzione può diventare insufficiente, rendendo necessaria una maggiore attenzione all’apporto alimentare.
Eccesso e sicurezza
L’eccesso di vitamina K è raro e generalmente non rappresenta un problema, tranne nei soggetti in terapia farmacologica anticoagulante, dove un apporto non controllato può interferire con l’efficacia del trattamento.