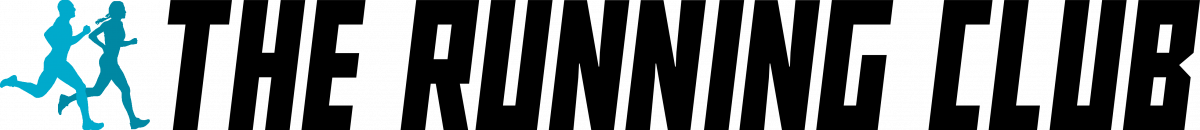In un’epoca in cui tutto sembra ruotare attorno alla velocità, anche nel mondo del running amatoriale si è diffusa rapidamente l’idea che per migliorare serva sempre spingere al massimo. Allenamenti intensi, occhio sempre sul cronometro, fatica come misura del progresso. Eppure, tra i runner professionisti, soprattutto nell’ambiente della maratona, si è sempre più diffusa una verità – dimostrata poi da diversi studi – tanto semplice quanto controintuitiva: per diventare più veloci, bisogna imparare a correre piano.
Sì, avete letto bene. Correre lentamente, con costanza e metodo, è una delle chiavi più efficaci per migliorare la propria performance. Non si tratta di una moda passeggera, ma di una strategia supportata da solide basi scientifiche e da anni di esperienza sul campo.
Zona 2: dove nasce la resistenza
Il cuore di questo approccio si chiama Zona 2 (ne abbiamo parlato qui). È una fascia di intensità cardiaca che corrisponde a circa il 60-70% della propria frequenza cardiaca massima. In pratica, è quel ritmo in cui puoi correre e parlare senza affanno, sentendoti a tuo agio anche dopo diversi minuti di attività. È la zona in cui si costruisce la base aerobica, quella che permette al corpo di sostenere sforzi prolungati senza andare in crisi.
Correre in Zona 2 significa allenare il cuore a lavorare in modo più efficiente. Il ventricolo sinistro, responsabile della spinta del sangue ossigenato verso i muscoli, si rafforza e diventa più capace di pompare grandi volumi di sangue a ogni battito. Questo si traduce in una maggiore ossigenazione dei tessuti e in una migliore capacità di sostenere la corsa nel tempo .
Ma i benefici non si fermano al cuore. L’allenamento a bassa intensità stimola anche la crescita della rete capillare nei muscoli, migliorando il trasporto di ossigeno e nutrienti. Questo processo, chiamato capillarizzazione, è fondamentale per aumentare l’efficienza del sistema aerobico.
In parallelo, si attiva la biogenesi mitocondriale: le cellule muscolari producono più mitocondri, le “centrali energetiche” che trasformano l’ossigeno in energia. Più mitocondri significano una maggiore capacità di sostenere sforzi prolungati, con un consumo più efficiente dei grassi come carburante principale. Questo è particolarmente utile nelle gare di lunga distanza, dove risparmiare glicogeno può fare la differenza tra un finale brillante e un crollo improvviso.
Correre piano non è perdere tempo
Uno degli errori più comuni tra i runner amatoriali è pensare che solo gli allenamenti duri portino risultati. Concezione e atteggiamento che spesso porta a trascurare l’importanza dei ritmi lenti. Il risultato? Allenamenti troppo intensi, troppo frequenti, e un corpo che non ha il tempo di recuperare. Il rischio di infortuni aumenta, così come la frustrazione per i progressi che non arrivano.
Correre piano, invece, permette di accumulare chilometri senza stress eccessivo, migliorando la resistenza e riducendo il rischio di sovraccarico. È un modo intelligente per costruire una base solida su cui inserire, al momento giusto, anche lavori più intensi come ripetute, fartlek o progressivi.
I benefici della corsa lenta non si vedono subito (come anche quelli degli allenamenti più intensi). Richiedono tempo, costanza e fiducia nel processo. Ma i risultati arrivano, e sono duraturi. Chi dedica una buona parte della propria settimana a corse lente e controllate scopre, nel tempo, di riuscire a correre più a lungo, con meno fatica e a ritmi più sostenuti.
È un cambiamento che avviene in profondità, a livello fisiologico, ma che si riflette anche nella testa. Correre piano insegna ad ascoltare il proprio corpo, a rispettarne i tempi e i segnali. È un modo per ritrovare il piacere del movimento, senza l’ansia della prestazione a tutti i costi.
Corsa lenta: non solo per principianti
Spesso si pensa che correre piano sia utile solo per chi inizia. In realtà, è una strategia adottata anche dagli atleti professionisti. I maratoneti kenyani, ad esempio, dedicano gran parte dei loro allenamenti a ritmi molto lenti rispetto alla loro velocità di gara. Questo consente loro di accumulare volumi elevati di corsa, migliorando la base aerobica senza logorare il corpo.
Anche per i runner esperti, quindi, la corsa lenta rappresenta un pilastro fondamentale. È il terreno su cui costruire la velocità, non il contrario. Senza una base solida, ogni tentativo di migliorare i propri tempi rischia di essere instabile e poco duraturo.
Un equilibrio tra le intensità
Naturalmente, correre piano non significa rinunciare agli allenamenti intensi. Al contrario, questi restano fondamentali per stimolare la soglia anaerobica, migliorare il VO2 max e abituare il corpo a gestire la fatica. Ma devono essere inseriti con criterio, in un contesto in cui la maggior parte del tempo è dedicata a ritmi più lenti.
L’equilibrio tra le diverse intensità è la chiave per un allenamento efficace e sostenibile. La corsa lenta non è un ripiego, ma una scelta strategica. È il fondamento su cui costruire tutto il resto.
Come iniziare a correre piano (davvero)
Molti runner credono di correre piano, ma in realtà vanno troppo forte. Per capire se sei davvero in Zona 2 (approfondisci qui), puoi affidarti a un cardiofrequenzimetro o semplicemente al “talk test”: se riesci a parlare senza affanno, sei sulla buona strada. All’inizio può sembrare frustrante rallentare, ma è proprio lì che inizia il cambiamento.
Inserire 2-3 uscite settimanali a ritmo lento, anche solo di 40-50 minuti, può fare una grande differenza nel medio-lungo periodo. È un investimento sulla propria efficienza, sulla salute e sulla longevità sportiva. Imparare a rallentare può essere un atto rivoluzionario. Correre piano insegna a costruire, a resistere, a migliorare con intelligenza. E, paradossalmente, è proprio così che si diventa più veloci.